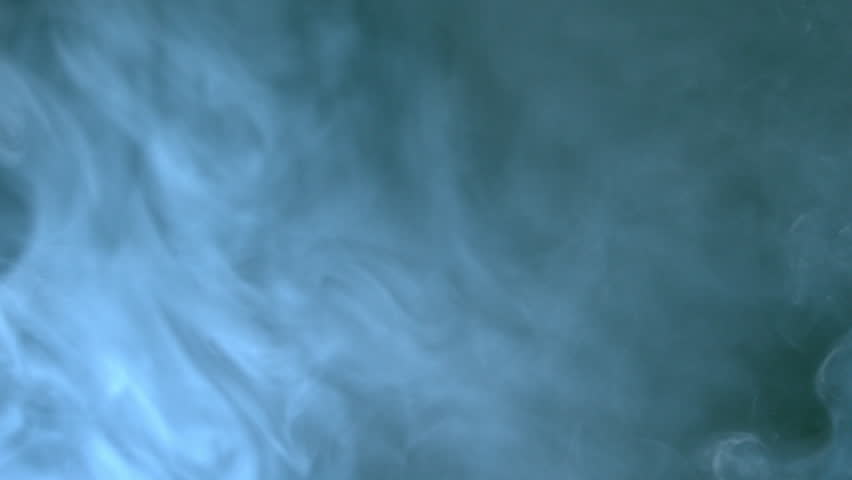È il pomeriggio di una giornata primaverile, gli anni ’90 stanno per finire e siamo in una dimensione quasi aliena, in cui le partite si guardano su Tele+ in enormi stanzoni nel retro dei bar, luoghi senza finestre, dove le sedie sono appiccicate l’una all’altra e tutti, ma proprio tutti, non fanno altro che fumare. Dagli avventori, perlopiù anziani, si levano generose boccate di fumo che salgono in alto a comporre un’enorme cappa di nebbia, una densa nuvola di Marlboro che domina la stanza e aleggia stantia, attaccandosi ai vestiti, ai capelli e ai polmoni, inquinandoli con la propria passività.
La partita è iniziata da un po’, io ho nove anni e non sono in grado di comprendere appieno il concetto di “metro arbitrale”. Gli altri picchiano durissimo e restano impuniti, di questo me ne accorgo, mentre i nostri vengono sanzionati senza esitazione al primo accenno di intervento; percepisco dei malumori che crescono in sala, ma non mi è del tutto chiaro, di preciso, cosa ci sia che non va.
Quando però il più forte dei nostri, il più forte di tutti, viene abbattuto in area, caricato con un intervento rugbistico, senza che l’arbitro trovi niente da obiettare; e quando invece lo stesso arbitro, nell’immediato ribaltamento di fronte, recupera di colpo la solerzia perduta e fischia un rigore senza alcun indugio… non c’è più niente da interpretare, o da capire. Non è necessaria alcuna nozione propedeutica per rendersi conto di ciò che è appena accaduto.
Accanto a me, mio nonno si toglie dalla bocca quella che potrebbe tranquillamente essere la cinquantesima sigaretta giornaliera e guarda i vari replay, con espressione accigliata e severa, le mandibole serrate, senza proferire parola.
Sento il bisogno che qualcuno mi dia una spiegazione, e quindi non riesco a trattenermi dal chiedergli sommessamente
“ma… perché?”
[fa un po’ tcrai, lo so, ma vi assicuro che è andata così]Lui si rimette in bocca la sigaretta, fa un tiro, espira spedendo tutto direttamente nella nuvola sempre più ingombrante che sorvola le nostre teste, e senza distogliere lo sguardo dal maxischermo risponde
“Eh.”
E basta, nient’altro. Solo “Eh.”
I replay ripartono, il loro numero 10 va sul dischetto, ma ormai la partita è finita, e con lei il campionato.
Quel giorno, la cruda realtà ha fatto la prima vera incursione nel mondo fantasioso e parziale che mi ero costruito fino ad allora, durante l’infanzia. E sì, forse fa un po’ sorridere affermare una cosa del genere in relazione a una partita di pallone, eppure è ciò che è accaduto.
Intendiamoci, mi ritengo fortunato, dato che fino a quel pomeriggio di aprile – e anche dopo, in realtà – ho vissuto relativamente tranquillo e al riparo da turbe preoccupanti. Non vorrei mancare di rispetto a chi i traumi li ha vissuti davvero a quell’età, e parlo di traumi veri, non di un rigore non dato alla propria squadra del cuore.
Però.
Però chi vive il calcio e il tifo con passione sa quanto possano essere totalizzanti e assoluti i sentimenti che derivano da una partita, positivi o negativi che siano, e sa anche quanto possa far male la sensazione di essere stati fregati.
E una fregatura così sfacciata, conclamata, palese, io non l’avevo mai vista. O meglio, non ero mai stato in grado di comprenderne una così profondamente, senza filtri; di sentirla mia, come se fosse stata commessa direttamente nei miei confronti.
Una delle più belle Inter di sempre, e di sicuro la più bella mai vista per chi aveva nove anni, era appena stata defraudata della possibilità di giocarsi lo scudetto nella gara più importante. Non di vincerlo: di giocarselo. Perché in quei 90 minuti, di fatto, non si è giocato. Si è fatto ciò che la Juventus ha ritenuto opportuno che si facesse. E la squadra di Pagliuca, di Bergomi, di Zanetti, di Simeone, Djorkaeff, Moriero e Zamorano, la squadra i cui giocatori potevano permettersi il privilegio di passare la palla al più grande attaccante di tutti i tempi e stare a guardarlo mentre faceva cose che non si erano mai viste, questa squadra ha dovuto subire quel sopruso. E con lei, tutti i suoi tifosi, e con tutti i suoi tifosi, anche i novenni, quelli che di uno come Ceccarini non potevano nemmeno concepire l’esistenza.
Si tratta, a tutti gli effetti, di una sorta di trauma infantile. Romanzando un po’, si potrebbe dire che quel momento è coinciso con la fine della mia infanzia, l’abbandono definitivo di un certo tipo di ingenuità. Soprattutto perché quell’ingiustizia (e non solo quella relativa al rigore, ma a tutta la partita, e in generale a tutto il campionato) è apparsa sin da subito come qualcosa di acclarato, qualcosa che – a meno di non essere dei professionisti della negazione dell’evidenza – non può risentire di troppe interpretazioni o rivisitazioni.
Quel giorno, per un bambino di nove anni, lamentarsi della partita non era un capriccio da viziatello frignone, abituato ai parenti che lo fanno vincere ai giochi natalizi e incapace di affrontare la sconfitta; era, piuttosto, la presa di coscienza che una cosa a cui si attribuisce grande importanza, in nome della quale si spendono tempo ed energie notevoli, funziona secondo logiche che non sono quelle che ci si aspetterebbe. E, di conseguenza, che anche il mondo è fatto così; che le cose possono andare male, anche se non si è fatto qualcosa per meritarlo.
È per questo, per il legame indissolubile che c’è con quel giorno, che ogni volta è tutto così difficile. È per questo che, quando accade qualcosa che anche solo in parte rievoca quel 26 aprile 1998, siamo costretti (specialmente coloro che al tempo erano piccoli) a fare i conti con dei fantasmi che ricompaiono lesti, vividi come la prima volta che si erano presentati. Ed è del tutto indifferente se ciò avviene in una partita importante o in una tutto sommato inutile, come quella di sabato. Quando Cuadrado ha dato un calcio a Perisic e si è lanciato per terra, ottenendo in cambio un tiro libero da undici metri con il quale ha deciso il risultato di Juve-Inter, l’ambiente intorno a me è scomparso, sostituito piano piano dalle pareti di quello stanzone pieno di anziani fumanti; sopra la mia testa si è formata nuovamente la nuvola di Marlboro, accanto a me è tornato mio nonno che avvicina la sigaretta alla bocca, e in tv è apparso Gigi Simoni che si dimena fuori dall’area tecnica e grida sdegnatamente “ma si vergogni”.

È successo la stessa identica cosa tre anni fa, nel macabro 28 aprile in cui ricorreva il (quasi) preciso ventennale del grande misfatto; e quella volta il tutto fu ulteriormente aggravato dall’importanza che quella partita rivestiva per l’Inter, a differenza di una giocata con lo scudetto già cucito sul petto. Le sensazioni, però, erano e sono sempre le stesse: la sofferenza originaria viene rievocata pura e intatta, così come l’impotenza dopo il fischio finale, col risultato che certifica la sconfitta e dà il là ai loro festeggiamenti, premiando il comportamento contrario a qualsiasi tipo di lealtà sportiva dei loro giocatori – Iuliano, Davids, Torricelli e anche, ovviamente, Conte nel ’98; Pjanic e Cuadrado nel 2018; e ancora Cuadrado, mefistofelico, insieme all’incredibile, inaudito Chiellini di ieri.
So bene che per superare i traumi infantili, di norma, è necessario l’ausilio di uno psicoterapeuta. Qui, però, non c’è granché da sviscerare: è chiara l’origine del trauma, così come sono chiare le sue conseguenze e la sua natura. È un’analisi piuttosto semplice, i fatti sono consci e indelebili, e il tutto è reso ancora più agevole dalle svariate rievocazioni di cui quel trauma ha goduto negli anni.
Col tempo, mi sono fatto un’idea di ciò di cui avrei bisogno per lasciarmi questi fantasmi (calcistici e non) alle spalle. E non è vederli sbugiardati di fronte al mondo e retrocessi in serie B, con trenta e più sentenze a certificare che no, le nostre lamentele non erano “gli alibi dei perdenti”, ma denunce di comportamenti illeciti, finalmente certificati come tali; e non è vedere l’Inter che vince tutto il vincibile nel giro di diciassette giorni, mentre loro arrancano a metà classifica rimanendo segnati per sempre, e nel profondo, da quella squadra e da quell’allenatore; e non è neanche vincere uno Scudetto con uno dei loro vecchi simboli in panchina, dandogli la possibilità di rendersi conto di cosa significhi disputare un campionato contro la Juventus.
Tutto questo è già successo, e non è bastato, perché dopo più di trenta ore sono ancora qua che penso alla faccia di Chiellini deformata da smorfie atroci, lancinanti, e a Cuadrado che si alza da terra invocando il fischio di Calvarese, che non tarda ad arrivare.
Riflettendo, ho capito che c’è una cosa che invece non è mai successa e che sortirebbe senz’altro un effetto immediato, restaurando una pace interiore attualmente irraggiungibile.
Dopo tanto peregrinare, ho finalmente capito di cosa ho bisogno: che mi chiedano scusa. Condividi il TweetNient’altro, solo questo. Vorrei che uno di loro venisse da me a dirmi “scusa“, e che ammettesse che quella roba del 26 aprile 1998 è una farsa inaccettabile, per la quale prova vergogna, così come la prova per tutte le sue successive rievocazioni. Vorrei che mi dicesse che non è possibile goderne perché è davvero ridicola, fatta male, raffazzonata; ci sono truffe eleganti, brillanti, ben organizzate, e c’è più di un caso in cui si può riconoscere loro persino una dignità. Ma questa no, questa è una recitina squallida, portata avanti da attori scarsi e beceri, da cui non emerge nient’altro che squallore e desolazione. Non ha davvero niente di divertente, non ha nessun lato positivo, porta con sé solo un esasperato patetismo.
Vorrei sentire queste scuse senza “ma”, “però”, senza passaporti, Oriali, Guido Rossi o qualsiasi altra baggianata possibile. Solo “scusa”, scusa a chi quel giorno aveva nove anni e non era in grado nemmeno di immaginare quello che stava per accadere, ma anche a chi ne aveva settantuno, o cinquanta o quanti ne volete, ed ha avuto la sventura di assistere a quello spettacolo allucinante.
Certo, perché ciò accada servirebbe che qualcuno riuscisse a liberarsi dell’elaboratissimo sistema di auto-convincimento costruito con fatica negli anni; quello che permette a chi si professa appassionato di calcio di continuare a tifare Juventus raccontandosi che sì, gli errori alla fine si compensano tutti, che gli arbitri sbagliano a favore della Juve come delle altre squadre, e che alla fine chi si lamenta sta solo rosicando.
È una cosa difficile, lo so, perché porterebbe quel qualcuno a rinnegare necessariamente l’intero modo in cui ha vissuto il calcio negli ultimi venticinque anni e, con ogni probabilità, a non vedere mai più una partita. Infatti, non posso nemmeno dire che ci spero, perché mi sembra davvero un’eventualità remota, improbabile; riesco solo a fantasticarci su, perché in fondo è solo una parola, priva di giri retorici. Una parola che certificherebbe la volontà di non rendersi complici, per quanto silenti, di qualcosa di tetro e avvilente.
Solo una parola, l’unica risposta possibile a quell’ “Eh.” che mi capita ancora spesso di sentire.